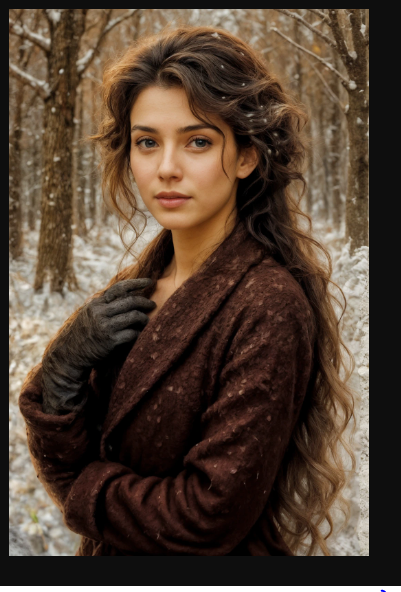Quella mattina Christina si era svegliata prima dell’alba, con l’idea fissa di arrivare al negozio in tempo per il pane caldo e quei dolcetti alla ricotta che le piacevano con il tè. Infilò in fretta i jeans, un maglioncino leggero, le vecchie sneakers ormai modellate sul piede. Fuori, il cielo era ancora grigio; una lama di luce cominciava appena a scivolare tra i palazzi.
Verso la porta di casa notò il corridoio invaso dai giocattoli del nipotino che ogni tanto le affidavano: una macchinina con le ruote lisce, un trattore di plastica senza benna—tracce della visita del giorno prima di un’amica con suo figlio. Sorrise, raccolse tutto e lo appoggiò sullo scaffale. Le piaceva che ogni tanto la casa si riempisse della risata di un bambino, anche se non era il suo. Non aveva figli—il lavoro, le scelte, e una storia finita da poco con un uomo “non pronto” a fare sul serio.
Prese portafoglio e telefono, li buttò in borsa e uscì. L’aria tiepida e il sole già deciso promettevano un’estate luminosa. Scese in ascensore, attraversò il cortile: due studenti fumavano su una panchina, un gruppo di nonne chiacchierava piano.
«Buongiorno, zia Valja!»
«Ciao, Christina. Sveglia presto?»
«Vado a prendere il pane.»
La donna le fece un cenno con la testa, sistemando la sciarpa. Christina puntò al “Pyaterochka” dietro l’angolo. Riempì il cestino: pane, formaggio, yogurt, frutta e qualche scatola di piselli per un’insalata. Pagò, infilò tutto in borsa e uscì leggera: giornata libera, nessuna corsa, un po’ di ordine in casa.
Rientrando, però, qualcosa la fece rallentare. Nell’androne una sconosciuta cullava un bambino; più in là un uomo al telefono gesticolava irritato. Christina stava per oltrepassarli quando un pianto minuscolo, quasi strozzato, le sfiorò l’orecchio come un fruscio. Si fermò. Ascoltò di nuovo. C’era davvero un vagito—debole, intermittente.
Il cuore le ebbe un sussulto. «Possibile che ci sia un neonato qui?» Fece qualche passo, appoggiando la spalla alla parete fresca.
«Sentite anche voi?» chiese piano.
L’uomo scrollò le spalle. «Niente, dev’essere il vento.»
«Suggestione» aggiunse la donna con il bambino.
Christina, però, era certa di aver sentito. Seguì il suono fino a una rientranza tra una colonna e vecchi mobili accatastati. Lì, avvolto in una copertina sottile e lisa, c’era un fagottino. Sollevò con cautela il bordo del tessuto: un neonato, piccolissimo—forse una settimana di vita. Le guance pallide, le labbra tendenti al blu.
«Oh Dio» sussurrò, sentendo la gola stringersi.
Il piccolo tremava. Non sembrava neppure avere un pannolino adeguato. “L’hanno lasciato qui”, le passò in mente come un coltello. Composero il numero di emergenza.
«Pronto, 118? All’ingresso del mio palazzo c’è un neonato abbandonato. È molto piccolo, respira ma sembra freddo. Vi prego, venite subito. L’indirizzo è…»
Restò accovacciata accanto a lui, mormorando parole rassicuranti che le venivano da sole. Quando arrivarono i sanitari, una dottoressa confermò che la situazione era delicata. Avvolsero il bebè in una coperta termica, lo misero sulla barellina; i vicini, ormai radunati, sussurravano frasi spezzate tra incredulità e vergogna.
Christina rimase lì, con le buste della spesa dimenticate ai piedi, a guardare le luci dell’ambulanza allontanarsi. Non riusciva a capacitarsi che qualcuno avesse potuto lasciare così, al freddo, una vita appena accesa.
La sera telefonò all’amica Oksana. Raccontò tutto, e le due finirono in silenzio, con le lacrime che arrivavano senza rumore, chiedendosi quale strada avrebbe avuto davanti quel bambino.
Nei giorni successivi la chiamò la polizia per raccogliere la sua testimonianza. Le dissero che il neonato era in terapia intensiva, stabile. La parola “orfano” le rimase addosso come una macchia che non andava via.
Un pensiero prese forma e non la lasciò più: provarci. Tentare di diventare la sua tutrice. Si informò, iniziò i corsi, mise insieme certificati, visite mediche, ispezioni domestiche. Ogni firma, ogni attesa, ogni colloquio era una salita, ma non smise.
Quando arrivò il decreto, le mani le tremavano. Pianse senza vergogna. Lo chiamò Matvej—un nome che per lei sapeva di dono e di coraggio.
La casa cambiò ritmo: notti interrotte, biberon, prime smorfie, risatine improvvise. Stanchezza e felicità si mischiavano in modo nuovo. Ogni traguardo minuscolo aveva il peso di una montagna scalata.
Seduta sul divano con Matvej addormentato sul petto, Christina capì che tutto aveva trovato un senso. Quel fagottino abbandonato nell’androne non era più un caso di cronaca—era suo figlio. E lei, finalmente, aveva una destinazione.