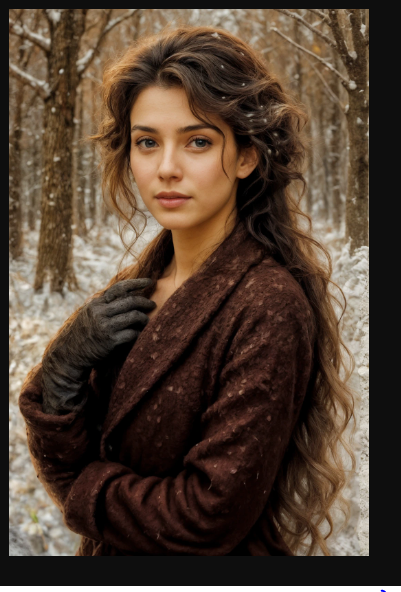La pioggia tamburellava senza tregua sulla tettoia dell’ingresso. Alla, seduta su una valigia, teneva stretto a sé il piccolo Misha, sei anni appena, tutto brividi e occhi lucidi.
«Mamma… è vero che papà non ci vuole più bene?» sussurrò, tirandole piano la manica.
Alla deglutì il nodo alla gola. Davanti a lei, due borse: l’unico bagaglio che Viktor le aveva concesso quando l’aveva cacciata.
«No, tesoro. Papà è solo molto arrabbiato», mormorò, provando a tranquillizzare lui e, in fondo, anche se stessa.
«Ma perché urlava? Ho fatto qualcosa di male?»
«Assolutamente no. Sono questioni da grandi.»
Il telefono era morto e il caricabatterie era rimasto a casa. E poi, chi avrebbe chiamato? Le amiche si erano dileguate col tempo, i suoi genitori vivevano in un’altra città, e Viktor le aveva reciso ogni legame—cosa che, scioccamente, lei aveva lasciato accadere.
«Alla! Che succede?» La voce familiare la fece voltare.
Era Nina Petrovna, la vicina del piano di sopra, lo sguardo pieno di premura.
«Niente di grave», tentò di sorridere Alla. «Un malinteso.»
«Con questo diluvio e un bambino? Non ti credo», ribatté la pensionata, afferrando una borsa. «Su, vieni da me. Beviamo un tè e ne parliamo.»
«Non voglio disturbare…»
«Sciocchezze. Ho insegnato per trent’anni: riconosco quando qualcuno ha bisogno d’aiuto. Il piccolo deve scaldarsi.»
Nella cucina di Nina, tiepida di cannella e vaniglia, Misha riprese colore. L’anziana versò il tè e gli mise davanti dei biscotti.
«Adesso dimmi tutto», disse piano, mentre il bambino guardava un cartone nella stanza accanto.
Le parole di Alla uscirono a fiotti.
«Oggi ho trovato dei messaggi tra Vitya e una certa Kristina. Stanno insieme da sei mesi. Non ha nemmeno negato. Ha detto che voleva lasciarmi da tempo, che mi sono trascurata, che a lui serve una donna giovane, non una “casalinga noiosa”.»
«E per questo ti ha lasciata sotto la pioggia?» s’indignò Nina.
«Ha detto che la casa è sua e mi ha dato un’ora per fare le valigie. “Ho diritto a essere felice”, ha aggiunto.»
Alla scoppiò in lacrime, ricordando lo sguardo freddo di Viktor mentre lei impacchettava, vietandole perfino di prendere gli oggetti “costosi” che—parole sue—aveva comprato lui.
«Sono stata una moglie irreprensibile per quindici anni», singhiozzò. «Ho lasciato il lavoro in contabilità, come voleva. Tutto per la famiglia. Ora ho quarantadue anni e non servo più a nessuno.»
«Sciocchezze», intervenne Nina. «Sei una donna splendida, solo messa all’angolo. E quei documenti della casa? Si controllano. Scommetto che lui nasconde qualcosa.»
«Viktor ha sempre ripetuto che l’appartamento è suo… Ci siamo sposati quindici anni fa. Non ho mai visto le carte.»
«Domani andiamo al centro servizi. Scopriamo chi è il proprietario. Adesso riposa.»
Quella notte Alla fu tormentata da incubi—Viktor che gettava via le foto con Misha, come a cancellare la loro vita. Al mattino, il campanello.
«Alla, è tuo marito», annunciò Nina. «Urla che tu scenda.»
Viktor l’aspettava all’ingresso, tamburellando le chiavi.
«Stai dando spettacolo ai vicini. Perché sei da lei? Dovevi andartene!» sbottò. «Comunque, ho portato le medicine per l’allergia di Misha. E…» esitò, «ci sono dei documenti da firmare.»
«Che documenti?»
«Una rinuncia volontaria a qualsiasi diritto sull’appartamento. Kristina verrà a vivere con me e non voglio guai. Se firmi, ti do dei soldi per l’affitto. Per un po’.»
Alla lo fissò: in quegli occhi non riconosceva più l’uomo con cui aveva vissuto quindici anni.
«Quella casa è la nostra. L’abbiamo comprata dopo il matrimonio.»
«Prove?» sogghignò. «Tu non hai tirato fuori un centesimo. Ho pagato tutto io. Dovresti pure ringraziarmi per l’offerta.»
«E Misha? Hai pensato a tuo figlio?»
«Non fare tragedie. Lo prendo nei weekend. Kristina ed io vogliamo un bambino, ma non abbandonerò Misha.»
«Un bambino?»
«Ha ventisette anni. Vogliamo una famiglia vera. Mi dispiace, ma è ora di voltare pagina. Quindici anni sono tanti—c’è chi non arriva a cinque.»
In quel momento Misha spuntò correndo.
«Papà!» Gli saltò al collo. Viktor lo strinse, impacciato, lanciando a Alla occhiate infastidite.
«Ciao, campione. Come stai?»
«Bene! Nina fa dei biscotti buonissimi! Papà, torniamo a casa?»
Viktor fece un passo indietro. «Vedi, a volte… insomma, mamma ti spiegherà. Devo scappare. Pensaci, Alla: è un buon accordo per tutti.»
L’auto scomparve e Alla lasciò andare il pianto.
«Mamma, perché piangi? Papà ti ha fatto male?»
Lei lo strinse. «No, amore. Ne usciremo. Te lo prometto.»
Risalì da Nina con un’energia nuova: non più disperazione, ma volontà. Quindici anni in silenzio avevano abituato Viktor a una donna che non reclamava nulla; forse proprio quel suo errore era l’occasione per rinascere.
«Mi ha offerto denaro in cambio della rinuncia alla casa», confidò.
«E tu?»
«È ora di riprendermi ciò che mi spetta.»
«Benissimo. Mia nipote è avvocatessa: ti aiuterà.»
Qualche giorno dopo, nello studio di Svetlana Igorevna:
«Eravate già sposati quando avete acquistato l’appartamento?»
«Sì, da tre anni.»
«E in tutto questo tempo ti sei occupata della casa e di tuo figlio?»
«Sì. Viktor voleva che lasciassi il lavoro: diceva che bastava il suo stipendio.»
Svetlana annuì. «Allora hai pieno diritto ai beni coniugali, a prescindere da chi ha firmato. Lo prevede il Codice della Famiglia.»
«Ma non ho documenti.»
«Li recuperiamo. Servono certificato di matrimonio, atto di nascita, estratti bancari…»
Una settimana dopo arrivò la visura catastale.
«L’appartamento è intestato a entrambi», confermò l’avvocatessa. «Ti spetta la metà.»
«Com’è possibile? Viktor mi ha sempre detto…»
«Ti ha manipolata. Le carte non mentono.»
Quel giorno Viktor telefonò.
«Che stai combinando?» ringhiò. «Perché sei andata al catasto?»
«Per capire perché mi mentivi sulla casa», rispose Alla, ferma.
«Non ricominciare: io ho lavorato mentre tu stavi a casa. Quella casa è mia.»
«Giuridicamente è nostra. Non firmerò nulla.»
Silenzio. «Te ne pentirai. Conosco gente che conta.»
«Le minacce non ti aiutano. Da ora in poi parla con il mio avvocato.»
Quella chiamata le diede coraggio. Alla non era più un’ombra.
«Mi serve un lavoro», disse a Nina. «Non voglio dipendere da nessuno.»
«Dipendere? Mi aiuti in casa e mi tieni compagnia. Per me sei un dono», protestò Nina.
«Lo so, ma Misha ha bisogno di una mamma forte.»
Con Svetlana mise insieme un curriculum. Le basi di contabilità erano rugginite ma presenti.
«Qui attorno ci sono centinaia di aziende», esultò Nina. «Una ti prenderà!»
E così fu: ricominciò come assistente contabile in una piccola impresa. Paga modesta, ma le permetteva di andare a prendere Misha a scuola.
«Mi piace vederti sorridere», le disse un giorno il bambino. «Hai anche un vestito nuovo. Sei bellissima.»
Alla lo strinse. Nei mesi seguenti era cambiata: aveva perso peso, un taglio di capelli nuovo, un altro modo di vestirsi.
«A volte bisogna perdere qualcosa per ritrovarsi», gli disse.
«E perché papà non viene più? Non ci vuole bene?»
Il cuore le si serrò. Dopo l’ultima lite, Viktor aveva telefonato solo una volta per dire che non sarebbe passato.
«Papà ha molto lavoro», rispose con cautela.
La causa per la divisione dei beni avanzava. Viktor assunse un avvocato costoso e provò a screditarla. Ma Svetlana non arretrava: «Vuole spaventarti. La legge è con noi.»
Una sera Alla, tornando dal negozio, riconobbe l’auto di Viktor sotto il portone.
«Papà!» Misha gli corse incontro. Viktor appariva stanco.
«Ciao», disse abbracciando il figlio e schivando lo sguardo di Alla. «Mi sei mancato.»
«Perché non venivi più?»
«Il lavoro», scrollò le spalle. Poi ad Alla: «Possiamo parlare? Da soli.»
«Misha, vai da Nina: arrivo subito.»
Appena il bambino fu via, Viktor cambiò tono.
«Che farsa è questa? Chiudiamola da adulti.»
«Da adulti? Lasciando moglie e figlio sotto l’acqua?»
«Ho sbagliato, ma mi ci hai trascinato tu col tuo modo di fare.»
«Non ti ho mai accusato. Ho cercato di essere la moglie perfetta.»
«E questo era il problema! Eri un robot: sempre d’accordo. Mi sentivo un mostro accanto a te.»
«Mi hai lasciata perché ero… troppo corretta?»
«Non lo so.» Si passò la mano sul volto. «Kristina mi ha piantato. Dice che sono egoista e tiranno. Puoi crederci?»
«Certo: volevi essere ammirato, non visto davvero—difetti compresi. Io ti vedevo.»
Negli occhi di Viktor passò un lampo.
«Sei cambiata.»
«Sì. Ho capito che la vita non finisce se tuo marito trova un’altra.»
«Sai che sei persino più affascinante adesso? Potremmo riprovarci. Per Misha.»
«No, Viktor. Né per lui, né per me. Tu non sei cambiato.»
Due mesi dopo, la sentenza: divisione equa dell’appartamento e dei beni. Viktor propose di riscattare la sua quota; Alla accettò. Con quei soldi comprò un bilocale nel quartiere accanto, per lei e Misha.
«Mi mancherete», sospirò Nina, aiutandola con gli scatoloni.
«Verremo spesso», promise Alla. «Senza di te non ce l’avrei fatta.»
«Altroché: ce l’hai fatta tu. A volte basta una spinta.»
Viktor mantenne almeno l’impegno col figlio e iniziò a vederlo con regolarità. Kristina era acqua passata; presto arrivò Lena, ancora più giovane. Alla non provava più gelosia—solo una tenue pietà per un uomo incapace di riconoscere ciò che aveva.
Un anno dopo, Alla fu promossa capo contabile. S’iscrisse a un corso d’inglese e, per la prima volta dopo vent’anni, andò al mare con Misha, in Turchia.
Seduta in aereo, la guardava disegnare palme e onde sul quaderno.
Tre anni prima, quando Viktor l’aveva lasciata sotto la pioggia, le era sembrato che tutto finisse. Oggi capiva: era l’inizio.
«Mamma, sai?» disse all’improvviso Misha. «Sono felice che siamo solo noi due.»
«Perché?»
«Perché adesso sei vera. Non ti nascondi più.»
Alla lo strinse forte. A nove anni, lui aveva colto ciò che lei aveva ignorato a lungo: non si può essere felici senza essere fedeli a se stessi.
A volte l’errore più grande di qualcun altro diventa la nostra benedizione più grande.