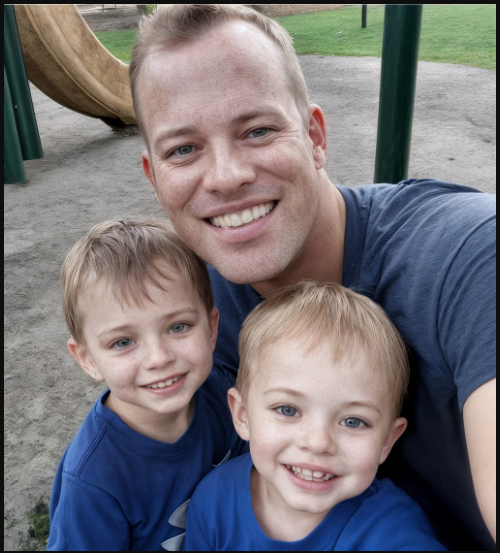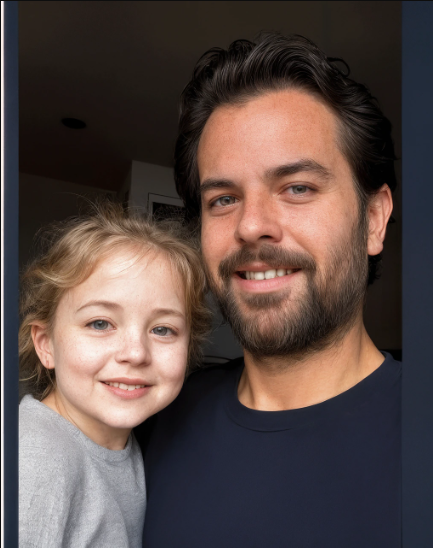«Perché non chiami tua madre dal villaggio? Falla venire qui a rimettere in ordine, visto che da solo non sei capace di combinare nulla.»
Quella frase, detta con un sorrisetto acido, tagliò il silenzio del salotto come una lama. Tutti rimasero di colpo immobili. Perfino Sasha, con il cucchiaino a mezz’aria sopra la tazza fumante, si bloccò. Il vapore che saliva dal tè sembrò stonato, quasi insolente in quella pausa carica di elettricità. Lena non urlò, non pianse. Si raddrizzò, tesa come una corda, e rispose con voce ferma:
— «Va bene. La chiamerò.»
Conosci quel dolore che non esce con le lacrime? Quello che non passa con una coperta calda o una carezza? Ti si pianta nel petto, stringe la gola, vibra nelle ossa. E ogni notte sussurra: «Non vali niente». Da due anni, da quando aveva sposato Sasha, quel sussurro accompagnava Lena.
Sasha era buono, attento. Ma fragile. E sua madre…
Ah, sua madre.
Tamara Alekseevna.
Uno sguardo capace di piegare il ferro e parole che tagliavano come coltelli invisibili, fino a scalfire la fiducia. Suo figlio aveva sposato Lena — una ragazza di campagna, con le mani abituate alla terra e nel cuore le ricette delle nonne, non certo le finezze della città.
Quanta avversione provava Tamara per quella semplicità. Ogni inflessione nella voce di Lena le dava i brividi. Il suo sorriso timido, lo sguardo basso, la gratitudine sincera — tutto diventava un pretesto per sminuirla.
— «La semplicità è peggio del furto,» ripeteva ai vicini. «E mia nuora ne ha così tanta che dovrebbero darla per reato.»
E non perdeva occasione per affondare un colpo:
— «È arrivata con la solita borsa sformata? Non siamo al mercato, sai.»
— «Non riesce neppure a tenere un bicchiere? Forse al villaggio beveva direttamente dalla lattina.»
— «Hai cucinato tu? Sì, si può mangiare… ma guarda come l’hai impiattato. Sasha ha persino spostato via il cucchiaio. Vero, tesoro?»
Sasha taceva. Sempre. E Lena, seduta al tavolo, serrava i pugni per non mostrare quanto facesse male. Ma come fai a ignorare chi ti trafigge senza toccarti?
Quella sera Lena indossò il suo vestito migliore: un grigio un po’ rigido, col colletto di pizzo. Così si sentiva speciale, perfino femminile. Si sistemò i capelli davanti allo specchio, ritoccò il rossetto. Sasha le prese la mano, la guardò negli occhi:
— «Andrà bene. Sono qui.»
Ma lui non capiva che da tempo non andava affatto bene. Non perché Lena fosse “di campagna”, ma perché lui permetteva che sua madre la ferisse, giustificandola sempre:
— «È solo preoccupata.»
— «È fatta così, non la cambierai.»
— «Bisogna solo sopportarla un po’…»
Era iniziato tutto in modo semplice: un amore quieto. Un ragazzo di città. Una ragazza di campagna. Lui in trasferta, poi rimasto lì. Per lei. O almeno così Lena aveva creduto.
Appena entrarono in casa di Tamara, Lena si sentì un’estranea. Quei quadri enormi alle pareti, il parquet lucidissimo, i lampadari di cristallo: tutto pareva guardarla dall’alto in basso, come a dire “non appartieni a questo posto”.
La suocera li accolse con un sorriso che sapeva di gelo:
— «Finalmente. Spero senza disastri.»
Lena tacque e strinse più forte la mano di Sasha.
— «Le hai spiegato come si usa il tovagliolo?» sogghignò Tamara. «Così magari la salsa non finisce di nuovo sulla tovaglia.»
— «Mamma…» provò Sasha.
— «Che c’è? Voglio solo che tutto sia perfetto,» fece lei, teatrale. «Questa non è una trattoria dove si mangia dalla stessa pentola e ci si pulisce sulle gonne.»
Sbuffò e scoccò a Lena uno sguardo pieno di disprezzo, come se avesse calpestato un tappeto bianco con stivali infangati.
— «Ti pare che bastino un po’ di rossetto e una piega per arrivare al mio livello? L’odore della campagna non te lo levi con il trucco, cara.»
Sasha rabbrividì, pronto a ribattere, ma vedendo le labbra serrate di Lena, si zittì. La colpa gli pesò addosso, e ancora una volta tacque.
— «Mamma, forse basta?» azzardò piano.
— «Dico soltanto la verità!» tuonò Tamara. «Prima si impara l’educazione, poi ci si siede a questa tavola.»
Non servono urla per umiliare. Basta il tono, una pausa, un sopracciglio alzato.
Lena provò a restare immobile, ma ogni parola le entrava sotto pelle come spilli. Finché, con quel sorriso velenoso, Tamara aggiunse:
— «Senti, la mia donna delle pulizie è ammalata. E tu — ragazza di fatica — chiama tua madre, la contadina. Pulire, strofinare, far bollire l’acqua… saranno pur cose che sai fare, no?»
Cadde un silenzio sordo.
Lena alzò lo sguardo e fissò Tamara negli occhi.
— «Va bene. La chiamerò.»
E, davvero, compose il numero.
Hai mai visto una donna che schiaccia gli altri con un’occhiata? Ora immagina quella stessa donna incrinarsi. Non con urla o pianti, ma nel silenzio.
Il giorno dopo, al suono del campanello, Tamara andò ad aprire con aria trionfante. Già pregustava la scena: fazzoletto in testa, borsa del mercato, un’ignorante di campagna. Che soddisfazione sarebbe stata.
Ma sulla soglia non c’era una contadina. C’era una donna sicura di sé, elegante, in un tailleur da lavoro. Capelli in ordine, mani curate, uno sguardo che faceva arretrare.
— «Buongiorno. Sono Nadežda Pavlovna, la madre di Lena.»
Qualcosa in Tamara si spezzò.
Ci sono momenti che cambiano tutto. Senza scenate. Una donna entra e dice soltanto:
— «Mia figlia non è una serva.»
E tu resti senza parole. Perché sei abituata a schiacciare, ma lei è abituata a resistere. E quella forza quieta fa più paura della rabbia.
— «Deve esserci un equivoco,» mormorò Tamara.
— «No,» rispose pacata Nadežda. «L’errore è tuo. Nel giudicare. Mia figlia. E te stessa.»
Seguì un confronto che nelle famiglie normali accade una volta sola — o non accade mai.
— «Pensi che mia figlia, perché viene dalla campagna, non sia degna di tuo figlio. Ma dimmi: chi sei tu per decidere?»
— «Sono sua madre.»
— «Anch’io sono madre. E ho insegnato a mia figlia a non umiliare gli altri.»
Il caffè restò intatto. Lena portò un tè alle erbe preparato dalla madre — camomilla, timo — profumo di casa, di conforto, d’infanzia. Si sedette accanto a lei e, per la prima volta da tempo, sentì che davvero le cose potevano andare a posto.
— «Vedi, tesoro,» sussurrò Nadežda, «non conta dove sei nata. Conta chi sei diventata.»
Scese un silenzio denso.
Poi Sasha trovò il coraggio e si mise tra le due donne:
— «Mamma, per favore, basta. Lena è mia moglie. La amo. Impara a rispettarla.»
Non gridò, ma nella voce c’era una fermezza nuova. In quel momento Tamara capì di star perdendo il controllo: su suo figlio, sulla situazione, sul mondo come lo conosceva.
Forse, per la prima volta, provò vergogna.
Pochi giorni dopo, Tamara chiamò Lena:
— «Devo chiederti scusa. Ho sbagliato. Mi vergogno.»
Lena fece una breve pausa.
— «Mi serve tempo.»
Sai, a volte la felicità è solo una tazza di tè in cucina, accanto a tua madre. Niente porcellane, niente cristalli, niente etichette.
— «Allora, com’è andata con la suocera?» chiese Nadežda assaggiando un biscotto allo zenzero.
— «Sta provando a cambiare,» sorrise piano Lena. «Forse ha capito che il rispetto non si compra: si guadagna.»
Forse è tutto qui, il senso delle cose.