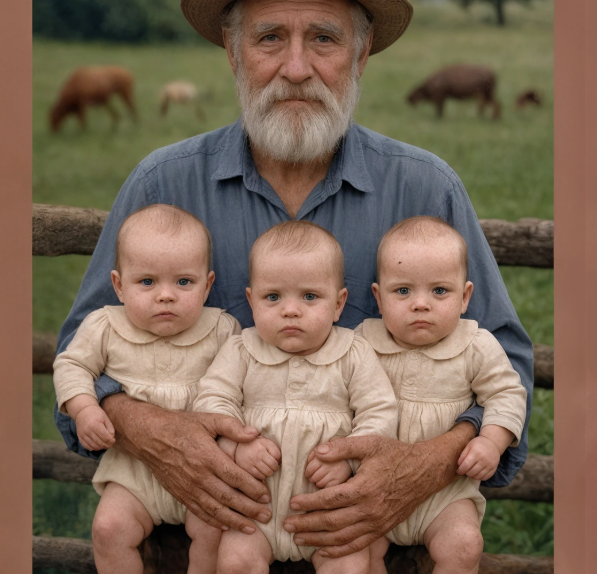«Che tempo tremendo oggi!» borbottò, fissando la nebbia lattiginosa che avvolgeva tutto intorno. «Spero solo di non incappare in una tormenta di neve lungo la strada…»
La tempesta infuriava con violenza, scagliando folate di neve e rendendo la strada un turbine gelido e insidioso. Mikhail si rannicchiò nelle spalle, cercando di difendersi dalle fitte punture di ghiaccio che gli trafiggevano la pelle. Dopo una giornata di lavoro faticosa, l’unico pensiero che lo spingeva a proseguire tra i cumuli bianchi era la prospettiva di una tazza di tè caldo in un angolo accogliente.
Finalmente, in lontananza, si delineò la sagoma del portone, un faro nel bianco infinito. Ma un flebile gemito lo fermò a pochi passi. Un suono sommesso, simile al fruscio di foglie morte mosse dal vento, cercava di farsi strada nel fragore della bufera. Mikhail tese l’orecchio, scrutando tra la neve.
«Aiuto… vi prego…» la voce si affievoliva come un cristallo che si scioglie sotto i raggi del sole.
In un primo momento pensò a un’illusione causata dal freddo, ma qualcosa dentro di lui gli suggerì che fosse reale.
«Ehi! C’è qualcuno?» gridò, coprendosi la bocca con la sciarpa.
Solo l’eco rispose, finché non udì di nuovo: «Qui… vicino…»
Avvicinandosi a una parete di neve, scorse una figura: una donna anziana, quasi sepolta dalla coltre bianca, con una mano affaticata che cercava disperatamente appiglio al bordo.
«Mio Dio!» cadde in ginocchio, sentendo la neve penetrargli nei pantaloni. «Come ci sei finita?»
Elena Sergeevna lo guardava come attraverso una foschia, il suo respiro si trasformava in piccoli sbuffi di vapore. I suoi capelli grigi, coperti di brina, sembravano un delicato velo di pizzo.
«Sono caduta… credo di essermi slogata qualcosa…» le parole le uscivano con fatica. «La gente passava, ma nessuno si è fermato…»
Mikhail tolse il piumino e lo avvolse intorno a lei, mentre il gelo lo trafiggeva. Tirò fuori il telefono e chiamò i soccorsi, riscaldandole le mani tremanti con le sue.
«Tieni duro, stanno arrivando i medici» le sussurrò, massaggiandole le dita intirizzite. «Non ti lascerò sola, te lo prometto.»
Nei suoi occhi comparve una scintilla di speranza, e un lieve rossore colorò le guance spente.
«Come vi chiamate?» chiese per distrarla dal dolore.
«Elena Sergeevna…» rispose piano, quasi sollevata.
«Io sono Mikhail. Stai tranquilla, andrà tutto bene» le spazzò via la neve dal volto.
Passò un tempo che sembrò interminabile, finché la sirena dell’ambulanza ruppe il silenzio. I soccorritori, con le giacche blu, apparvero dal turbine come angeli usciti da una favola.
«È vostra parente?» chiese il medico, alzando un sopracciglio.
«No, solo un passante» rispose lui, ma la donna lo interruppe:
«È il mio angelo custode!» disse con voce tremante, ma ferma. «Senza di lui…»
Il medico annuì socchiudendo gli occhi. «Volete accompagnarla?»
Mikhail guardò le luci della sua casa, che brillavano come occhi gentili. Dopo un attimo di esitazione, salì sull’ambulanza insieme alla barella.
Nell’ospedale, l’aria era intrisa di odore di disinfettante e di una tristezza sorda. Aspettava mentre i medici completavano le pratiche, sobbalzando a ogni cigolio delle ruote della barella. Un’ora dopo un dottore, il volto segnato dalla fatica, si avvicinò.
«Alla vostra conoscente hanno diagnosticato una frattura al collo del femore e ipotermia. Ha bisogno di riposo» si appoggiò al muro. «Ha chiesto di voi: si preoccupa che vi siate ammalato. Un’attenzione rara per uno sconosciuto.»
Un nodo gli serrò il petto. Quella donna, salvata dal gelo, si preoccupava per lui.
«Quando posso farle visita?»
«Domani, dopo pranzo. Ora è sotto flebo.»
Uscendo, un’infermiera gli restituì il piumino, impregnato dell’odore dell’ospedale. Lui annuì, ormai insensibile al freddo che ora gli sembrava uno scherzo.
La mattina seguente, i raggi del sole si riflettevano sui mucchi ghiacciati. Mikhail, con un cestino di mandarini e un thermos di cioccolata calda, si affrettava lungo i vialetti puliti.
Elena Sergeevna, nel reparto, sembrava una fragile statuina di porcellana. Supportata da cuscini, con sul comodino un mazzo di fiori di campo, dono delle infermiere.
«Siete tornato!» i suoi occhi, limpidi come laghi, brillavano di gioia. «Temevo fosse stato solo un sogno…»
«Sapevo che sarei venuto» disse lui, sedendosi vicino, notando le sue mani che stringevano la coperta. «Come vi sentite?»
«Meglio, grazie. Non sapete…» tossì leggermente, le lacrime affiorarono. «Mio figlio non risponde ai messaggi… E voi…»
«Non c’è di che,» scrollò timidamente le spalle. «Parlatemi di voi. Cosa facevate prima?»
Lei raccontò degli anni trascorsi come insegnante, del figlio trasferitosi in una grande città, dei nipoti visti solo attraverso lo schermo del computer. Mikhail ascoltava, cogliendo ogni parola come un prezioso racconto.
Fuori, i fiocchi di neve volteggiavano in un lento valzer, e il rumore dell’ospedale si affievoliva. In quel momento capì che il destino li aveva messi insieme per una ragione.
«Sapete, Mikhail,» confidò un giorno Elena Sergeevna, «quando sono caduta nella tempesta, non avevo paura della frattura. Temevo di scomparire… di diventare un’ombra.»
Mikhail prese la sua mano fragile con delicatezza:
«Non succederà. Ora ci sono io.»
Lei sorrise a fatica:
«Siete più gentile di tanti. Ma non voglio essere un peso per un giovane.»
«Non siete un peso» disse lui stringendo la sua mano. «Siete diventata parte del mio cuore.»
E così era davvero. Nei giorni passati insieme in ospedale, Mikhail si era affezionato a quella donna saggia, vedendo in lei non solo una pensionata sola, ma il custode di un’epoca che svanisce.
Il giorno della dimissione, Mikhail arrivò in anticipo. Elena Sergeevna, avvolta in un vestito dai fiori sbiaditi, cercava di sistemare i capelli ribelli.
«Ecco tuo nipote!» esclamò un’infermiera sistemandole il cuscino.
Elena aprì la bocca per smentire, ma Mikhail la anticipò:
«Sì, sono qui per portarla a casa. Tutto è pronto?»
Davanti al portone li aspettava un’auto straniera lucida, e un uomo altezzoso al volante. Appena fermatosi, lui scese di scatto.
«Mamma! Finalmente!» esclamò Andrei, il figlio, ma senza calore. «Vi presento Sergey e Olga,» indicò la coppia elegante. «Compreranno il tuo appartamento. Il prezzo è ottimo, te lo ricordi?»
Elena oscillava lo sguardo tra lui e gli sconosciuti, stringendo il bastone finché le nocche divennero bianche.
«Non ho firmato… non ho acconsentito…»
«E cosa c’è da decidere?» ribatté Andrei con freddezza. «Hai già firmato. Ecco qui.»
Mikhail, fin lì in silenzio, fece un passo avanti:
«Posso vedere?»
Andrei lo guardò con disprezzo:
«Chi siete? Questi sono affari di famiglia!»
Mikhail prese i documenti e il sangue gli si gelò: la firma era stata apposta mentre Elena era in rianimazione.
Sergey e Olga si scambiarono uno sguardo imbarazzato, mentre Andrei divenne rosso di rabbia.
«Mamma, basta drammi! Non puoi stare da sola. Quei soldi ti garantiranno un futuro sicuro.»
«Voglio restare qui!» tremava Elena, ma con fermezza. «In questo appartamento c’è il profumo della tua infanzia, i tuoi passi, le crepe sul soffitto…»
«Qui c’è solo muffa e vecchiaia!» sbottò Andrei. «Vivi con me, in condizioni migliori!»
Mikhail si mise tra loro come uno scudo:
«Se Elena Sergeevna non vuole vendere, la vendita è illegittima. Non potete farlo.»
Andrei lo fissò con sdegno:
«Toglietevi di mezzo, ragazzo. Non sapete di cosa parlate.»
«So bene ciò che dico,» estrasse il telefono. «Ho già chiamato un avvocato e un notaio. La firma è stata apposta sotto effetto di analgesici. È frode.»
Sergey e Olga si ritirarono verso la porta.
«Forse torneremo più tardi.»
«No!» Andrei afferrò il braccio della madre. «È deciso!»
«Nulla è deciso!» Elena strappò il braccio. «Rimango qui. Non vendo!»
Mikhail raccolse con cura una vecchia fotografia caduta: ritraeva Elena con Andrei da giovane, lui sorridente.
«Vi ricordate com’era?» chiese a bassa voce. «O avete cancellato anche questo?»
Andrei si bloccò, ma subito si irrigidì.
«Non capisci. Quel bilocale è un peso. Meglio venderlo.»
«Un peso?» Elena si appoggiò al bastone. «È il nostro rifugio. Tuo padre ci ha lavorato, qui hai fatto i compiti…»
Non concluse: le lacrime le rigavano il volto. Mikhail la strinse a sé, sentendo il suo tremore.
«Calmatevi. Vi aiuterò. Insieme ce la faremo.»
Andrei rimase lì, con i pugni chiusi, e Mikhail capì che per lui quello non era più un figlio, ma uno straniero che vedeva l’appartamento come un semplice bene.
Più tardi, quando i compratori se ne andarono e Andrei sbatté la porta, Elena sedeva in cucina, accarezzando una vecchia cassetta del pane.
«Perché è diventato così?» sussurrò. «Una volta questo posto gli dava gioia…»
«Perché ha dimenticato le sue radici,» rispose Mikhail, versandole un’altra tazza di tè. «Ma glielo ricorderemo. Insieme.»
Per la prima volta dopo tanto tempo, una scintilla tornò nei suoi occhi.
Nel silenzio ovattato della stanza, Andrei fissava Mikhail con ostilità.
«Non capite,» disse fra i denti serrati, «voglio solo garantirle sicurezza. Dopo la frattura non può restare sola.»
Mikhail sfiorò il bordo consumato delle tende, quasi traendo forza da quei ricami antichi.
«Siete sicuro che sicurezza significhi disporre del suo appartamento di nascosto?»
Elena, immobile come un orologio antico, si raddrizzò. Con voce fragile come ghiaccio all’alba disse:
«Andrei, non lascerò questo appartamento. Qui risuona il tuo riso da bambino, il profumo di tuo padre, le crepe sul soffitto mi parlano degli anni passati.»
Il figlio sussultò, come colpito nel profondo.
«Come farai a vivere? E se cadi di nuovo?»
«Non sarà sola,» intervenne Mikhail, stringendo la mano di Elena. «La aiuterò, la vicina Tamara la visiterà. Organizzeremo tutto.»
Andrei, voltandosi, scagliò sul tavolo la cartellina con i documenti. I fogli caddero come foglie d’autunno.
«Fate quello che volete!» sbottò, sbattendo la porta.
Elena rimase seduta, le dita che giocavano con l’orlo della coperta.
«Era il mio bambino…» mormorò. «Ma perché il cuore non segue la ragione?»
Mikhail prese una foto di Andrei da bambino, appoggiata su un mobile.
«Perché lui ricorda ancora questo posto,» disse, posando la foto sul comodino. «Ha solo dimenticato l’odore dell’amore.»
La sera, seduti intorno a un vecchio samovar, Elena riscaldava le mani sulla tazza e raccontava:
«Dicevo sempre ai miei alunni: “La vita non è una linea retta, ma un labirinto. A volte cadi nella neve per incontrare chi ti tende la mano.”»
Sette mesi dopo, quando il glicine era ormai fiorito e appassito, bussarono alla porta. Sullo zerbino comparve Andrei, con la cravatta slacciata e un mazzo di fiori tremolante.
«Scusa, mamma,» la voce tremava come foglia al vento autunnale, «ho vissuto come in una nebbia.»
Elena lo abbracciò in silenzio. L’adolescente figlia di Andrei, nascondendo un sorriso dietro i fiori, sussurrò a Mikhail:
«Non smette mai di parlare di lei. Per lui siete come un raggio di sole in un freddo giorno d’inverno.»
Più tardi, quando gli ospiti se ne andarono, Elena guardava i fiocchi danzare fuori dalla finestra.
«Sai, Misha,» gli occhi brillavano, «cadere in quella neve è stato il mio salvataggio. Mi avete insegnato che la famiglia non sono quattro mura, ma chi è disposto a difenderle.»
Mikhail, osservando un vecchio album di fotografie, rispose:
«Mi avete insegnato che la gentilezza torna da cuori inattesi, proprio come quei fiori che spuntano tra le crepe dell’asfalto.»
La loro conversazione fu interrotta da un’altra chiamata: Tamara li invitava a prendere il tè con la torta. Elena, prendendo il bastone, scoppiò a ridere.
«E la vita, a quanto pare, comincia ora. Grazie per avermelo fatto capire.»