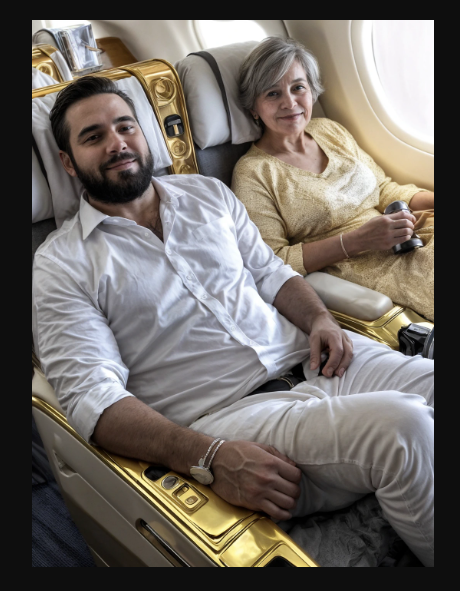Dodici anni dopo che il mio ex marito, George, mi aveva lasciata sola con nostra figlia appena nata, il suo nome è riapparso sullo schermo del mio telefono. Nessun preavviso, nessuna spiegazione: solo l’urgenza di “dover assolutamente rivedere Jennie”. Ho acconsentito, ma quando mia figlia è tornata dall’incontro con le lacrime agli occhi, ho capito che di genuino, nelle sue intenzioni, non c’era proprio nulla. Qualcuno mi ha accusata di aver ostacolato il rapporto tra padre e figlia; io, invece, so di aver protetto mia figlia. Ma lasciate che vi racconti tutto dall’inizio.
Dodici anni fa, il giorno dopo il nostro rientro dalla clinica con la piccola Jennie, George è semplicemente sparito. Senza un biglietto, senza un messaggio. Non lo trovavano gli amici — che, a dire il vero, non ho mai ritenuto davvero affidabili — e non lo trovavo io, con in braccio una neonata e nessun lavoro a cui aggrapparmi. Non avevo il lusso di rincorrerlo: dovevo cambiare pannolini, contare le monete e fare in modo che mia figlia mangiasse. Non si è più fatto vivo, né una telefonata, né una cartolina per il compleanno. A un certo punto ho chiesto il divorzio e non ho preteso un centesimo: volevo solo chiudere il capitolo. Dodici anni dopo, la chiamata da un vecchio numero. Era lui.
— Emily, sono George. Devo vedere Jennie. Ho notizie terribili — ansimava, come se le parole gli mancassero.
— Sono passati dodici anni, George. Davvero pensi di poter comparire così e pretendere di vederla? — gli ho risposto, con la voce che tremava per lo sdegno.
— Ti prego, non posso spiegare al telefono. Sono malato. Terminale.
La rabbia mi ha attraversata come una scossa. — Stai mentendo, vero? — gli ho detto, fredda. — Hai lasciato me e tua figlia senza uno straccio di contatto. Non so nemmeno più chi sei.
— Lasciami vederla almeno una volta. Voglio rimediare, prima che sia troppo tardi.
Ho respirato a fondo. Forse a Jennie serviva guardare suo padre negli occhi almeno una volta, chiudere un cerchio.
Il giorno seguente ci siamo presentate davanti a un bar. Jennie, curiosa ma agitata, è entrata da sola; io sono rimasta in macchina, con lo stomaco annodato e mille domande sulla presunta malattia di George. È tornata dopo pochi minuti, il volto stravolto, e mi si è gettata addosso.
— Mamma, lui dice che sta morendo… ma non posso fare quello che mi ha chiesto.
— Cosa ti ha chiesto, amore? — ho domandato, già sapendo che la risposta mi avrebbe ferita.
Una pausa, poi un sussurro: — Vuole che gli prenda dei soldi… per pagare le cure.
Mi si è gelato il sangue. Manipolare una ragazzina per estorcerle denaro: ecco il suo “ultimo desiderio”. Ho inghiottito la furia per non spaventare Jennie e l’ho stretta forte.
— Non preoccuparti. Me ne occupo io.
Tornata a casa, ho deciso di verificare. Ho telefonato a Frank, un vecchio amico di George.
— Malato? Terminale? — ha esitato. — Emily, non ne so niente. Non me ne ha mai parlato.
Quella frase mi è bastata: la sua malattia era, nella migliore delle ipotesi, un’esagerazione; nella peggiore, una bugia.
Quando Jennie mi ha detto che lui voleva rivederla il giorno dopo, ho accettato. Stavolta, però, non sarei rimasta a guardare. Prima che scendesse dall’auto, le ho consegnato una scatolina di “medicine” comprata in farmacia e una busta chiusa.
— Dagli questi insieme — le ho detto, cercando un sorriso rassicurante. — E poi torna da me.
Nella lettera c’era tutto ciò che George doveva finalmente sentire: la cronaca puntuale dei dodici anni che non ha vissuto, i giorni di febbre passati da sola con Jennie, i compleanni con una sedia vuota, la scuola senza una firma paterna sui moduli, le notti in cui mia figlia ha chiesto “Dov’è papà?” e io ho cambiato discorso per non farle male. C’era anche la verità sulla sua “malattia”: finché non avessi ricevuto conferme mediche, avrei considerato quelle parole per ciò che sembravano — un pretesto. E soprattutto c’era una condizione chiara, definitiva: niente più incontri a due, niente pressioni su Jennie, niente richieste di denaro. Se voleva davvero farsi conoscere, si sarebbe presentato con un certificato in mano e una responsabilità adulta nelle azioni, non con una storia lacrimosa e un’elemosina travestita da cura.
Jennie è rientrata in auto con il respiro più regolare e i pugni meno stretti. Non mi ha raccontato ogni dettaglio — non gliel’ho chiesto. Mi è bastato vedere che la sua schiena non tremava più.
Qualcuno dirà che ho messo un muro tra padre e figlia. Io dico che ho messo un tetto sopra la nostra casa: perché l’acqua della manipolazione non ci allaghi più. Se George vorrà, davvero, potrà bussare alla porta giusta — con verità, rispetto e prove. Fino ad allora, la mia priorità resta la stessa di dodici anni fa: proteggere Jennie. E questa volta non mi farò più cogliere impreparata.