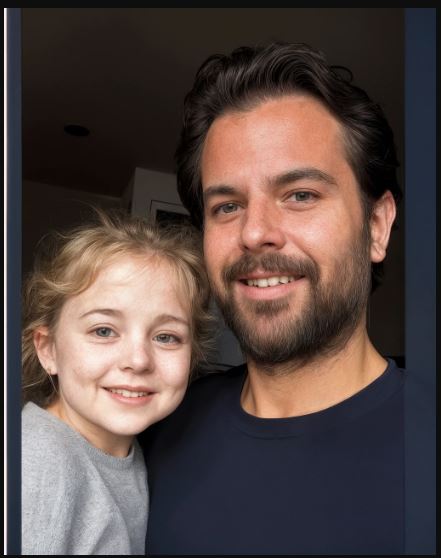Igor stava seduto nel suo ufficio come se fosse una stanza blindata, una di quelle dove il mondo resta fuori e dentro rimane solo ciò che fa male. Perfino l’orologio sembrava essersi ammutolito: il ticchettio non arrivava, o forse era lui a non sentirlo più. Fissava l’angolo del tavolo in noce, il punto esatto in cui la venatura formava una piccola cicatrice scura, ma la sua mente era altrove — inchiodata a casa, alla camera da letto, a quel letto dove era convinto che Kristina stesse spegnendosi piano, giorno dopo giorno, e che la colpa avesse il suo nome.
Un bussare leggero lo riportò in superficie. Non un colpo autoritario: un tocco esitante, quasi gentile.
La porta si aprì appena e apparve Olga.
Per gli altri era “la vice”, la donna che teneva insieme l’azienda con precisione e discrezione. Per Igor, da mesi, era diventata l’unica cosa capace di far respirare la sua vita. Entrò con il solito passo composto, ma quella volta non portava con sé la sua luce. Il viso era tirato, le labbra serrate, gli occhi troppo lucidi.
Si avvicinò alla scrivania e, senza dire nulla, posò davanti a lui un foglio piegato in due.
Dimissioni.
Igor lesse una riga, poi un’altra, e sentì qualcosa spezzarsi come vetro sottile.
— Olga… che significa? — la voce gli uscì ruvida, come se non la usasse da giorni.
Lei abbassò lo sguardo, stringendosi le dita.
— È la cosa più giusta, Igor. Per tutti — mormorò. — Ho già accettato un posto altrove. In un’altra città.
Il dolore gli attraversò il petto con una calma cattiva, una lama lenta. Si alzò di scatto, aggirò la scrivania e le prese le mani. Erano fredde, quasi senza sangue.
— Non farlo… ti prego, non andare — disse, e si odiò per quella supplica che usciva senza dignità.
Olga tremò appena.
— Io non posso rimanere — sussurrò. — Tu hai una moglie. E tua moglie… ha bisogno di te. Devi starle vicino.
Quelle parole gli scavarono dentro.
— È colpa mia! — esplose, più forte di quanto volesse. — Se sta così è solo colpa mia! La nostra storia… la sta distruggendo!
Olga alzò finalmente gli occhi. Non c’era rabbia, non c’era accusa: c’era la stessa stanchezza disperata che lo divorava.
— Basta, Igor — disse, piano ma ferma. — Tu non sei Dio. Non puoi portarti addosso la vita degli altri come fosse una valigia. E non sei responsabile di tutto. Devi… lasciar andare.
Eppure lui non ci riusciva.
Nel suo cervello si accendevano ricordi che non lasciavano scampo, come un film che riparte sempre dal punto più crudele.
Il matrimonio con Kristina non era nato da un “sì” pieno: era nato da un accordo. Due famiglie, un nome, un vantaggio. Un’unione “adatta” — così l’avevano chiamata i genitori, come se la vita fosse un completo da cucire su misura.
Kristina era bella in modo impeccabile, e distante in modo altrettanto impeccabile. Ogni volta che lui provava a sciogliere quella distanza, lei rispondeva con fastidio, con un sorriso che non arrivava agli occhi, con una frase tagliente.
Non voleva figli. Li liquidava come se fossero un difetto di fabbrica.
— Rovinano tutto — diceva. — La linea, il corpo, la libertà.
Il suo mondo erano gli eventi, i salotti, le cene dove i bicchieri avevano più importanza dei sentimenti. Vestiti, gioielli, confronti. L’ossessione di brillare sempre un po’ più degli altri.
Igor, per lei, era utile. Un cognome. Un conto in banca. Un accessorio elegante da esibire accanto alla borsa firmata.
Poi era arrivata Olga.
E con Olga, senza che lui se ne accorgesse subito, era arrivata la sensazione opposta: calore. Presenza. Cura. Non chiedeva nulla, non pretendeva niente. C’era e basta. Gli portava un caffè quando vedeva che non aveva dormito, gli parlava con una sincerità disarmante, lo ascoltava davvero. E quando lo abbracciava, Igor aveva l’impressione che quell’abbraccio sapesse leggere le crepe che lui nascondeva persino a se stesso.
L’ultimo ricordo, però, era quello che faceva più male.
Era tornato da Kristina deciso a chiudere tutto. Divorzio. Verità. Fine.
Non era stata una scenata: era stato un teatro pieno. Urla che rimbalzavano sulle pareti, pianti come un’arma, oggetti lanciati, un piatto esploso contro i mobili. E poi, improvvisamente, Kristina si era portata una mano al petto ed era caduta sul tappeto, come se avesse spento un interruttore.
Da quel giorno: “malata”.
Letto. Cuscini. Pelle pallida. Voce sottile e pungente.
E medici che non arrivavano mai a una diagnosi chiara.
Tornare a casa era diventato un rito di espiazione. Appena varcava la soglia lo investiva quell’odore di medicinali e aria chiusa. Kristina lo aspettava nella stanza, sempre con la stessa frase pronta a infilarsi come un chiodo.
— Sei di nuovo in ritardo… — sospirava. — Non ti importa niente di me. Magari domani nemmeno mi sveglio.
Igor inghiottiva il nodo che gli strozzava la gola, si sedeva sulla poltrona accanto al letto e lasciava che il senso di colpa lo divorasse. Prometteva a se stesso che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di rimediare, pur di “salvarla”, pur di pagare il prezzo del suo tradimento.
Per questo, quando Kristina gli aveva parlato di un “professore famoso”, un luminare in grado di guarire anche ciò che sembrava inspiegabile, lui non aveva fatto domande.
Il medico arrivava due volte al giorno. Camice perfetto, mani curate, sorriso soddisfatto. Parlava con un linguaggio pieno di termini altisonanti e misteriosi, faceva iniezioni, cambiava farmaci, annotava cose su un taccuino come se stesse scrivendo il destino.
E ogni visita costava una fortuna.
Igor pagava. Sempre.
Non per fiducia — per punizione.
Quella sera restò fermo davanti al cancello di casa. Motore spento. Mani sul volante. Desiderava solo cinque minuti di silenzio prima di rientrare nell’inferno dei sospiri e delle accuse.
Un colpetto al finestrino lo fece sobbalzare.
Era la ragazzina che vedeva spesso nei dintorni. Un’anima di dieci, forse undici anni. Magra, giacchetta consumata, un secchio d’acqua opaca e uno straccio. Si arrangiava pulendo fari e parabrezza.
— Signore, le do una pulita ai fari? — disse con una voce allegra che stonava con tutto.
Igor annuì senza parlare e le porse una banconota ben più alta del necessario. La bambina lavorò rapida, precisa, poi afferrò i soldi. Stava già per scappare quando si voltò di colpo.
— Lei arriva sempre troppo tardi — disse secca, senza paura. — Provi, almeno una volta, ad arrivare prima.
E sparì nel buio, lasciandolo lì con quella frase addosso come una scheggia.
“Troppo tardi” per cosa?
Il giorno dopo, Kristina fu la solita Kristina.
— Non toccarmi — sibilò quando lui cercò di sistemarle il cuscino. — Tra poco arriva l’infermiera. Lei sa cosa fare. Tu vai pure in ufficio… tanto ami più il lavoro di tua moglie morente.
Igor uscì quasi con sollievo, ma l’ufficio non gli diede tregua.
Nel pomeriggio, affacciandosi alla finestra, vide ciò che lo terrorizzava: Olga nel parcheggio con una scatola di cartone. Dentro c’erano le sue cose. La osservò riporre la scatola sul sedile, salire in macchina, accendere il motore.
E andare via.
Per sempre.
Igor si sedette, poi non riuscì nemmeno a restare seduto: una disperazione feroce gli salì in gola, mischiata a rabbia contro se stesso, contro il destino, contro quella casa che lo teneva in ostaggio.
Si coprì il volto con le mani e pianse. Ma non erano lacrime che liberano: erano lacrime che bruciano.
E poi — come un fulmine — la frase della bambina tornò a colpirlo.
“Arrivi sempre troppo tardi. Arrivi prima.”
Prima… per vedere cosa?
Un impulso folle diventò azione. Afferrò la giacca, uscì dallo studio di corsa.
— Non ci sarò — buttò lì, senza spiegazioni, lasciando tutti interdetti.
Quando arrivò a casa, vide subito una berlina nera parcheggiata davanti. L’auto del professore.
A quell’ora?
Il cuore gli balzò in gola. Scese di scatto, spalancò il cancello e quasi corse verso l’ingresso. Si fermò sul pianerottolo.
Dalla camera da letto arrivavano… musica.
E risate.
Non i gemiti della malattia. Risate piene, leggere, vive.
Ogni passo verso la porta gli gelava lo stomaco. Spinse l’uscio.
La scena lo inchiodò.
Sul letto coniugale, completamente nudo, c’era il “luminare”. Kristina, in un negligé trasparente, ballava davanti a lui con un calice di champagne, ridendo, energica, luminosa. Più sana di quanto Igor l’avesse vista in anni.
Lo notarono con un paio di secondi di ritardo.
Il medico afferrò il lenzuolo per coprirsi. Kristina sbiancò.
— Kristina! — urlò Igor, con una voce che non riconobbe nemmeno lui.
— Non è quello che sembra! — strillò lei. — Fa parte della terapia!
— Della… che cosa?! — Il medico la fissò scandalizzato, poi sbottò: — Sei impazzita?! È stato un tuo piano dall’inizio! E metà dei soldi te li sei pure tenuti!
Igor sentì il sangue farsi fuoco.
Non provava paura. Provava lucidità.
Senza dire una parola, si voltò e scese nello studio. Dalla parete prese il vecchio fucile da caccia di suo padre — un cimelio che non toccava da anni. Tornò in camera.
Kristina e il dottore impallidirono di colpo.
Igor puntò verso il pavimento.
Lo sparo rimbombò nella stanza. Il colpo si conficcò nel parquet a pochi centimetri dal piede del medico.
— Avete cinque secondi — disse Igor con una calma spaventosa. — Per uscire da casa mia e dalla mia vita. Cinque… quattro…
Non arrivò a due.
Tra urti e inciampi, vestiti afferrati a caso, il medico e Kristina fuggirono fuori dalla stanza e poi fuori dall’abitazione. Poco dopo si sentì lo stridio delle gomme, la berlina che sgommava via.
Igor rimase solo, con la puzza di profumo estraneo e menzogna che gli anneriva l’aria.
Lo shock si sciolse in un pensiero unico, netto:
Olga.
Guidò fino al piccolo appartamento che lei affittava. Bussò — una, due, tre volte.
Gli aprì una vicina anziana, con gli occhi stanchi ma gentili.
— Non c’è più, figliolo — disse, e la frase gli cadde addosso come un macigno. — È partita poco fa. Mi ha lasciato le chiavi. Ha detto che il treno… parte tra un’ora.
Igor non ringraziò nemmeno. Riprese a correre, questa volta contro il traffico.
Passò col rosso. Superò macchine a destra e a sinistra. Tagliò strade come se la città fosse un labirinto che doveva cedere. Due volanti gli si misero dietro con le sirene spiegate.
Lui non le sentiva.
Nella testa, solo: “Devo arrivare in tempo.”
Arrivò con l’auto quasi davanti alla stazione, oltre una barriera improvvisata, fermandosi con un colpo secco. Scese.
La stazione era un mare di vite: valigie, voci, annunci metallici, bambini che piangevano, passi che correvano.
Cercare Olga era impossibile.
Il panico gli strinse la gola.
Vide una promoter con un microfono. Le si avvicinò e glielo prese quasi dalle mani.
— Solo un minuto, ti prego — disse senza fiato.
E prima che qualcuno potesse fermarlo, parlò.
La sua voce esplose dagli altoparlanti.
— Olga! Olya, se mi senti… fermati! Non partire! Ti prego! Non è come credi! Io ti amo! Io… non so vivere senza di te!
Ripeté quelle parole, voltandosi, cercando un volto tra cento volti. Le persone si fermarono. Qualcuno sorrise, qualcuno scosse la testa, qualcuno si commosse.
Due agenti si avvicinarono, decisi.
Poi una voce sottile, alle sue spalle:
— E la povera Kristina?
Igor si girò di scatto.
Olga era lì. Valigia accanto. Biglietto stretto in mano. Il viso rigato di lacrime.
Igor lasciò cadere il microfono, che rotolò sul pavimento. Si inginocchiò davanti a lei, senza pensare allo sporco, agli sguardi, ai poliziotti.
— Kristina non è mai stata malata — disse, spezzandosi. — Era tutto finto. Una trappola per tenermi legato. L’ho visto con i miei occhi. Perdona la mia stupidità… perdona la mia paura. Perdona il dolore che ti ho fatto.
Gli agenti lo afferrarono per le spalle.
— Signore, deve seguirci.
Ma attorno si levò un mormorio che diventò coro:
— Lasciatelo!
— Non vedete che sta dicendo la verità?
— È amore, santo cielo!
Olga si inginocchiò accanto a Igor e lo strinse in un abbraccio che sembrava volerlo tenere intero. Loro due, in mezzo al caos, a piangere come se si fossero trovati dopo una guerra.
I poliziotti si scambiarono uno sguardo, poi — quasi imbarazzati — lasciarono la presa e sparirono tra la folla.
Qualche ora dopo, Igor accompagnò Olga nel suo appartamento. Sembrava già vuoto: cassetti aperti, un armadio semi spogliato, scatole abbandonate a metà.
— Mi dispiace… — disse Igor, a bassa voce. — Avrei dovuto prepararti un posto, una vita tranquilla… invece ti ho lasciata a metà strada.
Olga non rispose subito. Si sedette sulla poltrona, lo sguardo perso, come se avesse viaggiato troppo anche senza muoversi.
Igor, in piedi, cominciò a fare qualcosa di semplice e definitivo: prese i sacchi dell’immondizia e iniziò a raccogliere nella sua testa — e poi nella realtà — tutto ciò che legava Kristina a lui. Vestiti, oggetti, carte. Non per vendetta. Per liberazione.
A un certo punto si fermò e guardò Olga.
— Dimmi una cosa — disse, cercando un tono leggero che non aveva. — Perché sei scappata così? In un giorno. Tu… non avevi nemmeno davvero un altro lavoro, lo sapevo. Perché quella fretta?
Olga alzò gli occhi. Erano colmi di lacrime nuove.
— Avevo paura — sussurrò. — Paura di parlarti fino in fondo e metterti davanti a qualcosa… che ti avrebbe spezzato.
Igor corrugò la fronte, incredulo.
— Più di quello che stavo vivendo?
Olga inspirò, come chi prende fiato prima di tuffarsi.
— Peggio sarebbe stato dirti che… sono incinta.
Il tempo, per un istante, smise davvero di esistere.
Igor rimase immobile. Il gesto istintivo di Olga — le mani al ventre, protettive — gli arrivò prima ancora delle parole.
Poi qualcosa dentro di lui esplose. Non rabbia. Non panico.
Gioia.
Una gioia improvvisa, violenta e pulita.
La sollevò tra le braccia e girò su se stesso come un ragazzino, ridendo con le lacrime.
— Ti amo — ripeteva, senza riuscire a fermarsi. — Mi senti? Ti amo. E amo il nostro bambino. Non vi lascerò mai. Mai.
Un anno dopo, Igor e Olga erano sulla terrazza della loro nuova casa. Nel giardino, una carrozzina bianca dondolava appena. Dentro, la loro bambina di tre mesi dormiva serena, con quel respiro leggero che sembra una promessa.
Kristina era diventata un capitolo chiuso. Ci erano stati scandali, avvocati, aule di tribunale, articoli pieni di veleno. Igor le aveva dato solo ciò che la legge imponeva. Nient’altro. Non un centesimo in più per comprare ancora il suo teatro.
E poi l’aveva lasciata al suo mondo di menzogne.
La ragazzina del secchio, quella frase al cancello, non se l’era dimenticata.
Quella stessa sera della stazione Igor l’aveva cercata davvero, come se dovesse restituire al destino un debito. L’aveva trovata: viveva in condizioni difficili, una madre gravemente malata, un padre senza lavoro.
Non fece beneficenza per mettersi a posto la coscienza.
Fece la cosa giusta.
Il padre ebbe un impiego nella sua azienda. La madre venne curata in una clinica seria, con medici veri. E la bambina, ogni tanto, veniva a trovarli: si sedeva in cucina, beveva tè caldo con una fetta di torta, rideva con la sua risata nuova, quella che non ha più fame dentro.
Igor, la sera, guardava sua figlia dormire, stringeva Olga a sé e capiva una sola cosa:
aveva attraversato il suo inferno personale per imparare una lezione semplice.
Non era nato per restare “troppo tardi”.
Era nato per arrivare in tempo.